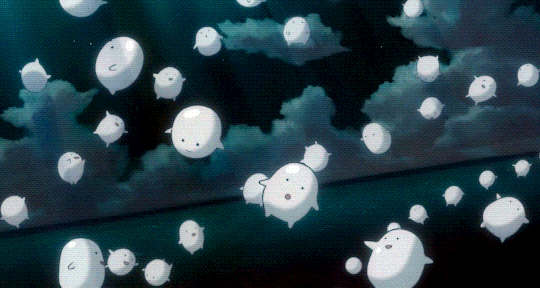Cos’è il lutto se non l’amore perseverante? Cos’è il lutto se non un processo delicato di accettazione? Ma se ricordare è amare nel tempo, non diventa amor proprio donarsi la possibilità di dimenticare per riuscire a proseguire lungo la via? Non di farne una tabula rasa, ma cercare almeno un poco, soltanto o appena, di maturare nella resa e proseguire sul cammino, anche quando nulla di ciò che avevamo o ci era stato, in parte, promesso per casualità, è rimasto intatto, dissipando un’esistenza che adesso a stento riconosciamo.
È Il Ragazzo e l’Airone (君たちはどう生きるか), scritto e diretto dal maestro Hayao Miyazaki a tentare una risposta a questi ed altri molteplici quesiti. E voi come vivrete? Non è, quindi, solo una domanda da aggiungersi alle altre, ma anche il titolo del libro di Genzaburo Yoshino, a cui il film si ispira nelle sue tematiche filosofiche, nonché dono che la madre del regista gli fece in passato.
Chi conosce la sua filmografia dello Studio Ghibli, già lo sa; dopo un memoriale capolavoro come Si Alza il Vento, il Maestro ritorna al pubblico con un’altra storia, un altro pezzo di anima e spirito, il quale, egli stesso, definisce il più sentito e autobiografico di sempre. Ci sono allora i suoi temi ricorrenti come la guerra, il lutto, la morte, il rinnovamento, il rapporto con la famiglia – nello specifico il legame con la madre – l’eterno ritorno di creature oniriche e bizzarre, il tutto contenuto in una teca di mondi illusori e pittoreschi.
Siamo a Tokyo nel 1943, la Guerra del Pacifico impazza e Mahito Maki perde la madre a seguito di un incendio che colpisce l’ospedale nel quale era ricoverata. Un anno dopo il padre si risposa e il ragazzo dovrà fare i conti con una nuova vita, nonché iniziare a conoscere la zia, diventata ora sua matrigna. È tanto da assorbire, ancora più difficile da accettare. Per farlo ci vorrà un intero viaggio attraverso la misteriosa torre che sovrasta i terreni della residenza di famiglia, e che, a detta di tutti, è pericolosa abbastanza da far sparire le persone. Un cammino questo, al pari delle cantiche dantesche, così Mahito verrà catapultato in un limbo metaforico dove non vi è tempo, ma ogni opposto coincide nella nascita e nella morte.

Negli ultimi anni, grandi autori hanno avvertito l’esigenza di plasmare i ricordi d’infanzia su pellicola, un viaggio della memoria condiviso col pubblico. Basti pensare a Steven Spielberg con The Fabelmans e Kenneth Branagh con Belfast, lettere d’amore al cinema ed al cuore pulsante chiamato casa. Ed Hayao Miyazaki non è stato da meno con la sua ultima creatura. Il Ragazzo e l’Airone infatti è semi-autobiografico e trae ispirazione sia dal passato che dal presente del regista. La storia della vita di Mahito è parallela a quella di Miyazaki quando entrambi fuggirono da Tokyo durante gli ultimi anni della seconda guerra mondiale e si stabilirono in campagna. Il padre di Miyazaki era un meccanico presso un’azienda che costruiva aerei da guerra, proprio come il padre di Mahito, Shoichi. Infine, Miyazaki ha quasi perso sua madre a causa della tubercolosi in giovane età, in modo simile a come la madre di Mahito è scomparsa in un incendio in ospedale. Anche se questi parallelismi potrebbero non sembrare ovvi alla prima visione del film, l’intimità tra creatore e creazione è palpabile, aggiungendo uno strato di profondità personale e connessione che arricchisce la narrazione.
Questa sensazione di intimità è elevata ancor più grazie alla meravigliosa animazione disegnata a mano. La tecnica tradizionale adoperata in questo film, chiamata cel animation, è la firma dello Studio Ghibli e non sembra mai passare di moda. Ogni fotogramma evoca emozioni, trovando il perfetto equilibrio tra bellezza e sangue, magia e dura realtà.

Chiunque abbia familiarità col lavoro di Miyazaki, potrebbe riconoscere diverse connessioni fra la sua ultima opera e quelle precedenti. In Il mio Vicino Totoro, anche la madre delle due ragazzine protagoniste è ricoverata in ospedale e costretta a letto, come la madre di Mahito. In Si alza il Vento, il protagonista progetta aerei da caccia giapponesi, rispecchiando la vita del padre di Miyazaki e di Mahito, per non parlare dell’ossessione del regista per il volo. In La Città Incantata, Chihiro entra in un mondo incantato – come accade a Mahito – spinta dal salvare i propri genitori.
“Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l’etterno dolore, per me si va tra la perduta gente.” – canto terzo, Inferno, Divina Commedia di Dante Alighieri
Il viaggio e la missione. Temi cardine della filosofia miyazachiana, emergono più vivi che mai ne Il Ragazzo e l’Airone. Un viaggio che assume sfumature dantesche sicché dinanzi alla misteriosa torre che separa il mondo dei vivi da quello onirico, un’iscrizione recita “fecemi la divina podestate”, medesime parole che si possono trovare incise sulla porta dell’Inferno dantesco. Perché in fondo, è proprio un luogo di morte quello in cui s’incammina Mahito, accompagnato dal suo personale Virgilio sotto forma di airone cenerino.

Non è una casualità che Miyazaki abbia scelto di servirsi di questo volatile che nel folklore giapponese simboleggia gli spiriti, le divinità, l’aldilà. Nell’antica Roma, il grido dell’airone era visto come un presagio di cambiamento, mentre nell’antico Egitto, l’airone era associato alla rinascita e si sospetta che abbia ispirato la leggenda della fenice. È il dualismo di Miyazaki, operare attraverso contraddizioni e libere interpretazioni, l’airone non solo come volto dell’inganno ma vero e proprio passepartout che Mahito adopera nel suo travagliato cammino.

L’ airone cenerino attira Mahito in un universo ai limiti dell’allegoria tentandolo con la speranza di riportare in vita la sua defunta madre. “So che è una bugia, ma devo vedere”, pronuncia Mahito prima di immergersi nell’oscurità. E se non è questa la confessione più personale di Miyazaki, non so quale possa essere, un uomo che raggiunta la veneranda età di 82 anni non può resistere dall’animare la sua storia personale, questa parabola allucinatoria per fare i conti – ancora una volta – col dolore e la mortalità. L’accettazione da parte di Mahito delle continue bugie dell’airone sottolinea come egli non veda necessariamente la falsità come qualcosa di negativo. “L’animatore deve inventare una bugia che sembri così reale affinché gli spettatori possano pensare che il mondo raffigurato potrebbe esistere”, scrisse Miyazaki in un libro illustrato nel 1979. Dunque l’intero universo del regista è una bugia animata, recitata con una maniacale attenzione al realismo. Non stupisce, del resto, che in questo film – come ne La Città Incantata – sia stata inserita una scena provvidenziale in cui il protagonista viene attaccato da migliaia di fogli di carta. Quale incubo peggiore per un animatore se non quelle di venir divorato dalla sua stessa opera?


Anche quando i corpi si sciolgono al solo contatto, la carta si anima come sciami d’insetti e gli uccelli assumono il volto di spietati killer divoratori di carne umana, Miyazaki trova sempre il modo di radicare il fantastico nel reale. Creature come l’airone e le orde di parrocchetti possono parlare, mutare la propria forma, ma si comportano comunque come dei veri uccelli. Scoprire il significato dietro ogni scena e il suo legame con il regista è parte di ciò che rende Il Ragazzo e l’Airone intrigante e non solo un film da guardare, ma sul quale riflettere – d’altronde lo stesso figlio del regista, Goro Miyazaki (col quale ha un rapporto complicato) ha confessato di servirsi dei film del padre per poterlo capire come persona. Più Miyazaki manipola in modo creativo il suo immaginario, alimentando ulteriormente la sua bugia, più invita il pubblico ad avvicinarsi maggiormente al suo lavoro.

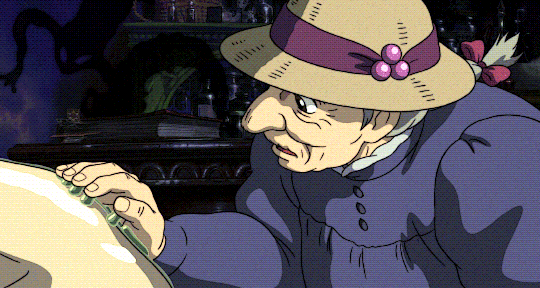
La morte. Come si è detto, è uno dei temi più persistenti negli elaborati di Hayao Miyazaki, qui anche citata nell’iconografia del dipinto Arnold Böcklin, “L’Isola dei Morti”. Best seller dell’arte, questo dipinto, suggerisce simbolicamente la quiete apparente del nulla, dell’assenza. Al vento calcante che ingrossa i mari circostanti e dove i cipressi si muovono come immense e minacciose ombre, vi è la premonizione della violazione, quando i cancelli verranno forzati e insieme a un esercito di pellicani, anche Mahito andrà oltre la soglia dei vivi rischiando di svegliare lo spirito nascosto della cripta. Chi sia, non ci è dato saperlo, ma tanto quanto il peso della conoscenza, portiamo con noi l’inesorabile consapevolezza che esista qualcosa oltre la soglia, qualcuno che non possiamo vedere ed è proibito risvegliare. L’unica azione che possiamo adottare è l’attesa o l’agire attraverso un viaggio divergente. Accade lo stesso ne La Città Incantata di come gli Orfeo ed Euridice orientali (Chihiro e Haku), compiano a loro volta un cammino verso un onirico e metafisico regno dei morti, dal quale dipartirsene sarà possibile soltanto se l’una avrà il coraggio di non voltarsi mai indietro verso l’altro.

“Non mollare mai la maniglia” insegna pertinace Himi, poiché, una volta lasciata, sarà impossibile ritrovarla e tornare indietro. E Mahito, si sa, deve tornare alla realtà, ma non prima d’aver portato a termine la sua missione. Missione che si trasforma sotto i nostri occhi dal “ritrovare la madre” (negazione della perdita) al “salvare zia Natsuko” (accettazione del lutto). Dopotutto Mahito, sin dall’inizio, nega a se stesso la possibilità di dimenticare, di lasciar andare quel dolore che lo attanaglia, ostinandosi nel cercare qualcosa che oramai non c’è più (la madre) così da avere una ragione di vita, un motivo per proseguire nel suo cammino. Ma è proprio quando forziamo l’inevitabile ticchettio dell’orologio dell’esistenza che tutto precipita ai nostri piedi, frantumandosi e tramutandosi in cenere. Miyazaki ci insegna ad accogliere il tormento, l’affanno, la colpa, a lasciar andare (come suggerisce Haku alla rinata Chihiro alla fine del loro viaggio). Mahito – e tutti noi – si autoconvince che andare oltre è impossibile poiché è terrorizzato dall’idea di vivere senza quella presenza, quella figura a lui cara, ma il dolore non ci abbandonerà mai, semplicemente lo si mette da parte, come un capitolo di un libro che abbiamo assorbito a sufficienza, pronti a immergerci in nuovi racconti.
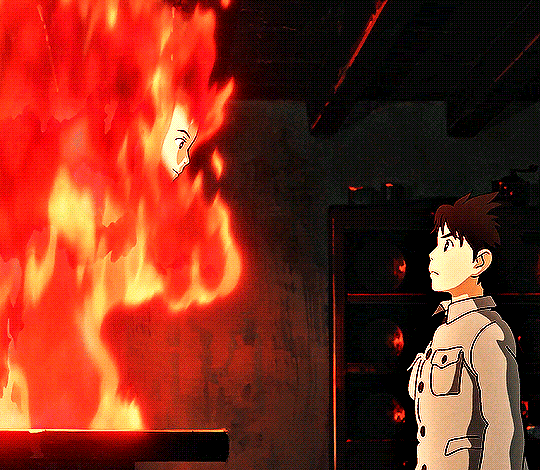
Per far questo, il ragazzo verrà affiancato dalla ragazza-fuoco (già sopracitata) Himi. Il pubblico già lo sa, lo intuisce – molto più di quanto non fosse ovvio nel rassomigliante Quando C’era Marnie – è una persona fortemente legata al protagonista, per sangue e per vita, e attraverso entrambi sboccia l’aiuto per Mahito da parte della sua famiglia in una commovente realizzazione. Va da sé, che ci sia sempre una tenera disarmante grazia, quando Miyazaki imbastisce certi connubi che sfidano e vanno oltre lo spazio e il tempo, a rammentarci che non siamo mai una sola entità; siamo parte integrante di un disegno più grande, un’unione di chi eravamo, di chi ci ha preceduti e di chi diventeremo.
Il fuoco qui assume un duplice ruolo: quello di distruzione e quello di calore (in questo caso, umano) e di bruciante desiderio di vivere. Le fiamme dirompenti e disarmanti della guerra mutano i tratti del viso e i contorni della abitazioni nella scena iniziale del film, pregna di una potenza visiva che solamente La Tomba delle Lucciole del collega Isao Takahata ha saputo offrirci. Non c’è da stupirsi se, in generale, il cinema nipponico sia così costantemente ossessionato dalla devastazione che ha causato la seconda guerra mondiale. Per quanta sofferenza abbia generato, il Giappone vuole ricordare, deve ricordare. Ed il cinema di Miyazaki è anche questo: tramandare la storia affinché non ci si volti mai indietro.

L’altro mondo si rivela presto essere un’isola circondata da un oceano infinito. La fonte della magia dell’isola fu un incidente, seminato da una misteriosa meteora caduta dal cielo che permise al prozio di Mahito di costruire la torre e prenderne il controllo. I riferimenti a Laputa e Il Castello Errante di Howl paiono ovvi. Sebbene l’isola sia un luogo di miracoli e rivelazioni, è anche una prigione. Il prozio di Mahito è isolato dalle altre persone e dalla realtà stessa, trascorrendo le sue giornate lottando per mantenere l’equilibrio, rappresentato dall’impilamento di tredici blocchi magici che si dice siano lapidi. Notare come il numero tredici non sia casuale poiché aritmico e cioè capace di rompere la legge dell’equilibrio e della continuità, simboleggiando così un cambiamento drastico che può essere sia positivo che negativo, così come la morte va interpretata come morte alchemica, cioè morire per poi rinascere. L’isola è, letteralmente, costruita su fondamenta di tombe, sui ricordi dei morti. Sembra perennemente sull’orlo del collasso e il film suggerisce che il prozio abbia preso molte decisioni discutibili durante il suo regno. Per codeste ragioni offre a Mahito, sangue del suo sangue, l’opportunità di creare un mondo fantastico perfetto, libero dalla sofferenza, ma il ragazzo rifiuta, rivelando una realtà che noi tutti conosciamo fin troppo bene: il dolore è essenziale, è parte del nostro vissuto e va accolto.

Mahito, come Ashitaka ne Principessa Mononoke, assume così il ruolo del prescelto, colui destinato a cambiare le sorti del mondo (anzi, dei mondi). Ma la figura dell’erede gli sta stretta, è indesiderata. Ciò ci porta a chiederci se il prozio altri non sia che Isao Takahata, collega e scopritore del talento di Hayao Miyazaki, o se quest’ultimo non vesta i panni del prozio di Mahito domandandosi chi possa prendere fra le mani il suo lascito. Non ci sentiamo di citare il figlio Goro, visti i suoi lavori di cui solamente La Collina dei Papaveri si può definire degno di nota per quanto lontanissimo anni luce dalla poetica e stilistica paterna. Del resto, forse non si tratta di una gara a staffetta in cui passare il testimone per poter vincere. Forse Miyazaki, nel dedicare questo film al nipote, vuole solamente rivolgersi alle generazioni future che, come Mahito, dovranno fare i conti con un mondo segnato dalla violenza, ma non per questo incapace di donarci bellezza.
Hayao Miyazaki, parlando del film Il Mio Vicino Totoro, una volta disse “I would like to make a film to tell children it’s good to be alive”. Allora perché, direte voi, siamo ancora qui a parlare di morte, dolore e perdita? Perché il pessimismo del Maestro è tale da fare il giro e ritornarci con la spinta infallibile della speranza. È quello che sanno fare i filosofi, dopotutto. C’è la morte, c’è la solitudine e il c’è il dolore, ma è forse questa consapevolezza a renderci forti, è forse l’accettazione della caducità del mondo e di noi stessi a liberarci dal fardello dell’esistenzialismo. Essere noi, nonostante tutto, essere noi nei nostri limiti attraverso la vita che ci accade, migliorarla nella realtà, senza più perdersi nel sogno – tanto effimero da bastarsi un Re Parrocchetto per metterlo a soqquadro.
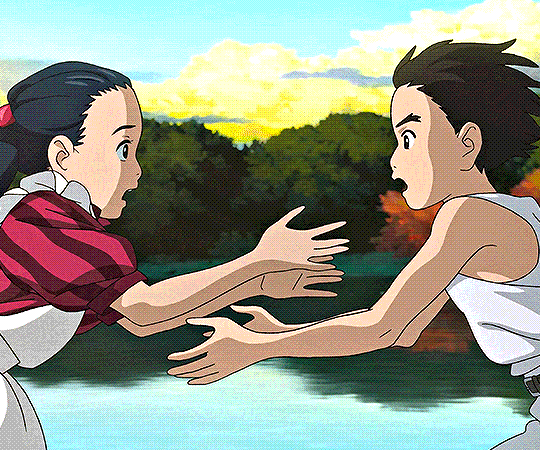
Allora, il mondo fantasy non sarà più la meta a cui ambire, ma l’ostacolo d’attraversare per tornare a casa, a quella quotidianità che ci rappresenta. È la grazia del piccolo che accetta l’umiltà: non serve conquistare lo scettro del mondo per evitarne il collasso; basta riportare con sé la madre putativa, salvarla e accettarla nella propria vita. Il Ragazzo e l’Airone sottolinea l’inevitabilità della morte, che sia essa di persone o interi mondi. Ma qualcosa di nuovo deve emergere dalle ceneri, Miyazaki però non pretende di sapere cosa potrebbe essere. Quando al leggendario regista è stato chiesto quale fosse la risposta al titolo giapponese del suo film, How Do You Live?, egli ha risposto: “Sto facendo questo film perché non ho la risposta.”
– Angelica e Laura