L’ondata di dolore che ha seguito la morte di David Lynch, il 15 gennaio 2025, mi ha colto di sorpresa, come sospetto abbia fatto a molti altri, per la sua portata ed intensità. Per qualche giorno, mi è sembrato che tutti avessero un sentito omaggio da condividere. Negli sconcertati messaggi di condoglianze reciproche che ho letto, scritti da colleghi, attori, musicisti e fan del regista, ho intuito che stavamo piangendo non solo un eccezionale artista, ma qualcosa di più grande e amorfo. Perché David Lynch ha significato così tanto, per così tante persone?
A soli cinque giorni dal suo 79° compleanno, il cinema ha perso uno dei più autentici visionari artistici. Una vera icona di culto che ha incoraggiato l’impegno e l’abbandono al suo lavoro per vivere esperienze più intense. Questa è di per sé la più concreta espressione d’arte di cui pochi registi sono capaci e la sua morte, a distanza di un anno, ha lasciato un’indelebile perdita per il cinema e la creatività in sé e per sé.
Il talento di Lynch non si limitava alla creazione di film, tuttavia: lui ha dato origine mondi, atmosfere e vuoti. Ha dato forma alla meraviglia della vita stessa: gli incubi, i paesaggi onirici, i meravigliosi e oscuri mondi paralleli in cui possiamo coesistere con doppelgänger. Il modo in cui riuscì a trasmettere tutto questo in forma cinematografica è stato semplicemente un’impresa miracolosa, qualcosa che sinceramente non credo rivedremo mai più nel corso della nostra esistenza. Lynch era un visionario unico, un artista autentico che riuscì a proiettare la sua arte, la sua astrazione, il suo surrealismo e la sua conoscenza dell’interpretazione dei sogni e delle illusioni cosmiche teoriche sul grande schermo, affinché tutti noi potessimo gioire, esplorare e rimanere confusi e sconcertati. David Lynch è stato il regista più astrattamente intelligente che abbia mai conosciuto e il suo approccio visionario è persino riuscito a divenire un vocabolo nel dizionario, infatti qualsiasi cosa inspiegabile o surreale viene ora descritta come “lynchiana”. Chi come lui?

Era un maestro nel combinare immagini e suoni e il suo rivoluzionario Twin Peaks del 1989 ha radicalmente cambiato la cultura pop e reinventato la televisione stessa. Senza di esso, forse non avremmo mai avuto il format delle serie TV che oggi diamo per scontato. Lynch è stato un pioniere e, grazie alla sua visione artistica senza compromessi, ha lasciato con le sue opere – sia cinematografiche che televisive – un contributo senza tempo all’intrattenimento che semplicemente si rifiuta di invecchiare per la sua natura enigmatica e l’opporsi ad essere catalogato o assecondato da narrazioni commerciali. È l’epitome di un vero artista che è riuscito ad esprimersi attraverso il mezzo cinematografico e ha mostrato cosa è possibile realizzare quando si superano i confini dell’espressione.
Non ha mai lavorato a livello cosciente, era pura suggestione e si compiaceva nell’esplorare l’intuizione e le interdimensioni tra il buio e la luce, trovando la bellezza nel macabro. Per molti, i suoi film non avevano senso, ma era proprio questa la sua intenzione. Si rifiutava di realizzare pellicole commerciali, per Lynch non si trattava di soldi, ma semplicemente di arte. La sua scomparsa ha lasciato il mondo del cinema in un ambiente più desolato, ma per fortuna avremo sempre il suo catalogo infinitamente rivedibile di genio assoluto a cui attingere, a cui tornare per trovare in qualche modo una forma di rassicurazione, di abbraccio per il cuore.

“Diane, ho sentito che David Lynch è morto. Sono le 11:30 del mattino del 16 gennaio. Eppure devo chiedertelo: Che anno è?”
Questo perché, per chi di noi ha accompagnato Lynch nel suo viaggio nei luoghi meravigliosi, spaventosi e bellissimi della mente umana, il tempo è una domanda, un mistero, non un dato di fatto. Tempo, spazio, dimensione e realtà sono concetti fluidi nel cinema di Lynch. C’è una stratificazione costante di riferimenti, richiami, anticipazioni e una bibliografia intricata in quasi ogni scena dei suoi film. Intellettuale consumato e innovativo, Lynch aveva una conoscenza enciclopedica della storia del cinema, della musica, delle belle arti, della letteratura, del teatro, della cultura pop, della filosofia, delle pratiche spirituali e del misticismo arcano/occulto. La sua visione cinematografica è un distillato della sua ambizione personale, che era quella di trascendere ogni cosa attraverso la conoscenza e il successivo abbandono del mondo così come appariva intorno a lui, alla ricerca di uno stato di coscienza che trascende le parole e la descrizione, fino a raggiungere il puro essere. Lynch ha scoperto la meditazione trascendentale a ventisette anni e da allora ha dichiarato di non aver mai saltato le sue due sedute giornaliere.
Riflettendo sul modo in cui Lynch ha inquadrato il suo mondo per noi con la macchina da presa, vale la pena considerare l’atto stesso del “guardare” in relazione al cinema. Quando guardiamo uno schermo su cui vengono proiettate immagini in movimento, non stiamo guardando la realtà, ma piuttosto una particolare versione di un universo creato per noi. Non è un caso che Lynch una volta abbia detto: “Non passa giorno che io non pensi a Il Mago di Oz”. Quando il nostro sguardo cinematografico è rivolto verso un’immagine, un momento, una scena e una storia particolari, stiamo osservando attraverso uno specchio tenuto da qualcun altro. Non dovremmo aspettarci di vedere noi stessi o qualcosa di simile a noi, eppure cerchiamo istintivamente personaggi con cui possiamo empatizzare o rrelazionarci.

A volte proiettiamo e riflettiamo le nostre fantasie su supereroi, a volte su persone comuni, a volte su creature fantastiche, ed altre volte ancora su villain terrificanti. Alla fine, è tutto proiezione e riflesso. Lo schermo è un portale, un vetro che riflette anche un minimo dettaglio di noi stessi. Ma chi è la persona che ci sta realmente guardando? Questo è uno degli infiniti quesiti che David Lynch ha posto al suo pubblico. Qui sorge l’amletico dilemma: forse non esiste affatto un sé “autentico”. Forse siamo – come direbbero i buddisti – in uno stato di “anatta”, o “non-sé”. Molti filosofi hanno esplorato quest’idea. Siamo la somma delle nostre esperienze, ambienti, informazioni, pregiudizi e influenze dal momento in cui nasciamo fino al presente. Ci muoviamo nel mondo indossando ogni giorno la maschera adatta alla nostra situazione. Nessuno può sapere chi siamo veramente perché nessuno è veramente nessuno.
Who is the dreamer?
Ciò che Lynch ha sempre compreso è che i sogni sono intrinsecamente umani. E i suoi film sono sogni ad occhi aperti. Non seguono una struttura logica, perché i sogni stessi non hanno bisogno di logica. Ma sono pieni di verità, verità emotive, verità sulla paura, il desiderio, la perdita. Queste verità non vengono rivelate tutte in una volta, ma attraverso strati successivi di immagini e suoni, frammenti che, seppur sparsi, risuonano profondamente dentro di noi.
Da spettatrice, mi sono spesso chiesta: perché David Lynch? Perché sono attratta dal suo lavoro quando spesso mi lascia confusa ed a disagio? La risposta è che Lynch ha creato spazi sicuri in cui sentirmi insicura. Non mi ha mai detto come pensare. Non mi ha mai offerto risposte chiare o finali rassicuranti. Al contrario, mi ha lasciato sensazioni, immagini che mi perseguitano anche dopo la fine dei titoli di coda, come enigmi che non smetti mai di risolvere.

Lynch aveva la rara capacità di trasformare l’invisibile in visibile. Non rendeva comprensibile l’insolito, ma ci invitava a riconoscere l’estraneità già presente nelle nostre vite. Quando sogno una casa che sembra allo stesso tempo familiare ed estranea, o una voce che mi chiama senza che io sappia a chi appartiene, realizzo che mi trovo in un mondo lynchiano. I suoi film ci chiedono di accettare questi paradossi, questi momenti in cui la logica cede il passo all’emozione pura. E forse è proprio questa la vera genialità di Lynch: ci ha mostrato che la vita stessa è un sogno. Un sogno a volte incoerente, a volte sublime, spesso spaventoso, ma sempre ricco di significati nascosti. Accettandolo, abbracciando l’ambiguità e l’incertezza, diventiamo più umani. Perché sognare è essere umani. E Lynch, attraverso la sua arte, ci ha dato la possibilità di sognare ad occhi aperti.
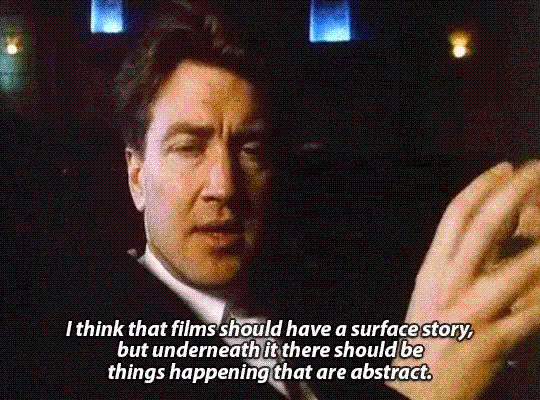
Ed ora, permettetemi di espormi in maniera più personale, intima, quasi voi foste il mio più caro amico a cui confessare incubi indicibili, lacrime e tremori, senza alcuna forma di imbarazzo.
David Lynch è morto ed a distanza di un anno, mi è rimasto un intero mondo di ansie, sensazioni e misteri intraducibili. Mi rimangono queste strade che si snodano attraverso foreste oscure, dove l’asfalto sembra fluttuare in una notte infinita, come un nastro spettrale sospeso tra due realtà. Mi rimane una lampadina sfrigolante, che diffonde una luce tremolante, quasi viva, come se custodisse segreti insondabili. Mi rimane una musica che evoca una tristezza così profonda da finire per suonare come una forma di meraviglia, venata di malinconia, dove ogni nota sembra contenere un universo intero. Mi rimane il suono delle tende rosse che si muovono in un vento inesistente, come le pagine di un libro che nessuno ha mai scritto. Come spettatrice, sono allo stesso tempo orfana e per sempre tormentata dal mondo che Lynch si è lasciato alle spalle.
La morte di David Lynch è più di una semplice perdita per il cinema. È come se un’intera porzione di realtà – una che ci era familiare, ma sempre priva di uno strumento per comprenderla – fosse crollata con un boato sordo. Lynch era una porta, ma non una porta qualunque. Una porta che si apriva a malapena, che scricchiolava come se portasse il peso di secoli di mistero, ma la cui fessura lasciava entrare una luce allo stesso tempo attraente ed agghiacciante, una luce che sembrava sussurrare verità dimenticate. Oggi, quella porta è chiusa. Ma l’eco che ha lasciato risuona ancora, e in quell’eco persiste una domanda: cosa rimane?

Nei suoi film, Lynch non ci ha mai dato spiegazioni chiare, ma ci ha offerto qualcosa di più prezioso: un invito a sentire, a sperimentare. “The meaning is in the experience”, era solito enunciare. E se posso dire di aver vissuto delle esperienze, sono proprio quelle delle sue opere. Mulholland Drive mi ha lasciato con le vertigini, come se avessi camminato in un labirinto le cui pareti erano fatte di ricordi. Twin Peaks mi ha accompagna per anni, un’ossessione che mi ha spinto a rivedere ogni episodio come se rivivessi un sogno che non vuoi dimenticare, un sogno che senti contenere qualcosa di essenziale ma che ti sfugge sempre. Inland Empire è stato il suo primissimo film che ho avuto la fortuna di sperimentare seduta al cinema, uno di quelli vecchio stampo, che trasuda polvere e vissuto. E ricordo come se fosse ieri la sensazione totalizzante di disarmo che quel film mi ha lasciato, uscendo dalla sala con l’espressione attonita, confusa, eppur colma di meraviglia. Ma ciò che mi colpisce di più oggi è quanto David Lynch fosse, in fondo, uno scultore di percezioni, un alchimista capace di trasformare il banale in sublime.
David Lynch non c’è più, ma ci ha lasciato in eredità una mappa. Non una mappa che ci porta ovunque, ma una mappa che ci mostra come esplorare i mondi che portiamo dentro di noi. E se questa mappa a volte è sfocata, è perché possiamo percorrere il resto del cammino, perché possiamo inventare i percorsi che non sono ancora stati tracciati. È sia una guida che un mistero, un invito a perderci per poi ritrovarci. Ogni deviazione, ogni vicolo cieco ci insegna qualcosa, come se la vera destinazione non fosse mai la meta, ma il viaggio stesso. Lynch ha sempre capito che la bellezza dell’arte risiede nelle sue ombre, in ciò che non può essere pienamente illuminato. I suoi film, come questa mappa che ci ha lasciato, non sono risposte, ma domande aperte. Ci dicono che l’incertezza non è una debolezza, ma una forza. Quando mi perdo nei suoi film, non è un vagabondare inutile: è un’esplorazione delle mie zone d’ombra, dei miei sogni e incubi. Ogni inquadratura, ogni silenzio, ogni guizzo di luce è una chiave che apre una porta su qualcosa che ancora non sapevo fosse dentro di me.
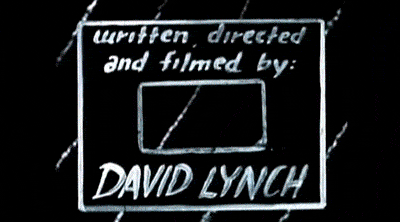
David Lynch non è morto. Non davvero. È lì, in ogni angolo troppo scuro, in ogni silenzio troppo lungo, in ogni sogno che non comprendiamo ma che comunque custodiamo. È nel tremolio di un’insegna al neon, nelle parole che cerchiamo di dire ma che non troviamo mai. È nella tensione tra il familiare e l’insolito, in quell’attimo fugace in cui il banale diventa straordinario, quando l’invisibile si manifesta in un respiro. E forse questa è la sua vera eredità: ricordarci che l’ignoto non va temuto, ma accolto. Che l’arte, come la vita, non ha bisogno di risposte definitive per avere un significato. David Lynch è quel sussurro nel buio, quella luce che indugia ai margini della coscienza, quell’invito a non smettere mai di cercare, anche se non sappiamo esattamente cosa speriamo di trovare.
Dunque cosa potrei mai dire ad un essere umano del genere, che ha concretamente mutato il mio modo di vedere il mondo giorno per giorno? La risposta è semplice, forse scontata, ma un sincero grazie è ciò il buon caro David più si merita. Ed una promessa, sussurrata nella notte. Quella di non smettere mai di sognare.
Grazie, maestro.


Angelica
